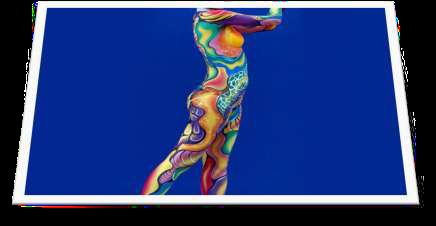di STEFANIA POZZI
Nel corso della mia attività come psicologa ospedaliera ho avuto modo di occuparmi di persone con problematiche cardiovascolari, giovani alle prese con malattie infiammatorie intestinali croniche, adulti che affrontano il cancro e persone che, per svariati motivi, vengono sottoposte a interventi chirurgici con elevato impatto sull’immagine corporea. Mentre nei primi due casi la ferita, fisica ed emotiva è soprattutto interna, negli ultimi due casi i segni della malattia e degli sforzi per sopravvivere sono evidenti.
Ciò non significa per forza che sia un bene, anzi, nel condurre gruppi di giovani affetti da morbo di Crohn e Colite Ulcerosa, una questione delicata era proprio la difficoltà a sentire un riconoscimento sociale per il proprio stare male. Dall’altra parte, quando le terapie o gli interventi chirurgici modificano in modo sensibile e improvviso l’esperienza che ognuno fa del proprio corpo, l’esperienza è come di essere scossi nelle fondamenta.
Il nostro corpo è infatti il primo ambito dove l’essere umano può fare esperienza di se stesso, dove si sviluppa la coscienza di sé e dell’incontro con l’altro (un incontro fra corpi in interazione). Noi diamo un senso soggettivo alle esperienze perché qualcosa nel nostro corpo ci fa “sentire” bene o male, in un modo o in un altro. Il neuroscienziato Antonio Damasio ritiene che le persone, per poter operare delle scelte nella loro vita di tutti i giorni, si basino sulle sensazioni di piacevolezza/spiacevolezza, sicurezza/pericolo, che si attivano nel corpo, e di cui il corpo ha memoria, tramite i cosiddetti “marcatori somatici” delle esperienze.
Quando il rapporto fra la nostra consapevolezza e gli input provenienti dalle varie parti del nostro corpo viene alterato, ci si può trovare in una condizione di confusione e spaesamento. Ad un livello estremo questo si manifesta in sindromi neurologiche che insorgono – a volte – dopo l’amputazione di parti dell’organismo: la “sindrome dell’arto fantasma”.
Nel nostro cervello esiste una mappatura di tutte le aree del corpo, sia rispetto alla sensibilità (tattile, interocettiva) sia rispetto ai comandi motori dei vari muscoli; ogni area cerebrale specializzata si attende di ricevere una informazione puntuale dai distretti corporei corrispondenti, ad esempio l’area della mano riceve input dalla mano reale, ad es. informazioni sulla posizione e l’orientamento spaziale della mano, sul livello di tensione muscolare o distensione, e così via. Quando la mano reale viene mozzata via, rimane un buco nella catena di comunicazione fra parti distali dell’organismo e sistema nervoso centrale. Al cervello i conti non tornano, perché non arriva più l’informazione prevista. Talvolta può capitare che altri input vengano dirottati erroneamente nella parte del cervello lasciata in disuso dalla deprivazione sensoriale.

In questi casi, alle persone può capitare di continuare a “sentire” l’arto amputato, pur essendo perfettamente consapevoli della sua mancanza reale. Spesso ciò prende la forma di dolori, sensazione di spasmi muscolari e altre forme di percezione fastidiosa. L’equipe del neurologo indiano Ramachandran ha approfondito molto questi aspetti, sviluppando procedure di riabilitazione neuropsicologica adatta a ri-tarare il cervello sulle nuove condizioni.
Negli anni, comunque, è stato appurato che sindromi del genere possono manifestarsi anche a seguito di interventi chirurgici diversi dall’amputazione di un arto. Nelle persone con tumore intestinale che vengono sottoposte a resezione del retto (solitamente con confezionamento di una stomia), può capitare di soffrire della cosiddetta “Sindrome del Retto Fantasma”. Recentemente, svolgendo un gruppo con uomini operati di stomie intestinali e urinarie, alcuni di loro riferivano sintomi analoghi, ma inerenti la vescica, come la sensazione di dover urinare, o uno stimolo continuo alla minzione, pur sapendo benissimo che i chirurghi avevano asportato loro la vescica per intero.
Riporto questi aneddoti per spiegare come, anche ad un livello neurale, il cambiamento dell’immagine corporea comporti una grande quantità di “confusione”, che richiede tempo e molte energie mentali per poter essere compresa e dipanata. Al cortocircuito comunicativo, si aggiunge la necessità di sostenere importanti pesi emotivi, che sempre accompagnano le persone e le loro famiglie nell’incontro con la malattia.
Per alcuni accettare i risvolti negativi delle terapie viene in modo abbastanza naturale. Per altri l’esperienza può essere di una sorta di “patto col diavolo”, dove la posta in gioco riguarda la loro sopravvivenza fisica (garantita da trattamenti invasivi), che viene barattata con la vendita della propria anima emotiva (il costo psicologico delle cure).
Immagine corporea e vita quotidiana
A volte le terapie farmacologiche o la chirurgia trasformano in profondità l’immagine corporea, ossia la rappresentazione mentale e affettiva del proprio corpo. In questi casi, a livello psicologico si ha una duplice esperienza: da un lato una perdita di funzioni (per es., l’impossibilità di urinare o defecare in modo “normale), dall’altro l’introduzione di un “corpo estraneo” (es. cicatrice, protesi artificiali, etc.) che deve entrare a fare parte dell’immagine complessiva di se stessi.
IL CASO DELLE STOMIE
Prendo il caso delle persone operate di stomia, perché me ne occupo ormai da molti anni e perché esemplifica in modo estremo certi passaggi psicologici che in forme diverse toccano anche altre malattia. Si tratta di un intervento che può rendersi necessario a seguito di rimozione parziale o totale dell’apparato intestinale, urinario o dei reni, per malattie oncologiche, infiammatorie croniche, incidenti stradali con traumi addominali, malformazioni, e una miriade di altri motivi, più rari rispetto ai primi due. In sostanza l’intestino o il sistema urinario non possono più funzionare e vengono “deviati” chirurgicamente verso l’esterno dell’addome, dove viene operata una apertura (lo “stoma”) e viene posizionata una sacca per la raccolta delle feci o delle urine. Da quel momento, persone adulte smettono di avere un controllo sui propri sfinteri. Possono occuparsene, imparando a gestire la stomia grazie al percorso riabilitativo, possono prevenire inconvenienti come la fuoriuscita eccessiva di materiale, tramite accorgimenti nell’igiene quotidiana e nella dieta, ma non possono controllare volontariamente il funzionamento dei loro organi interni.
Questo controllo, di solito, si acquisisce intorno ai 2-3 anni di vita. I bambini non imparano a togliere il pannolino da un giorno all’altro: vi sono tutta una serie di processi preparatori, come l’osservazione di ciò che fanno gli adulti, l’ascolto dello stimolo, i primi tentativi di usare il vasino (inizialmente sotto forma di gioco). Allo stesso modo, dopo una stomia il processo con cui si ri-conoscere il proprio organismo fino a sviluppare un nuovo senso di normalità, richiede tempo, pazienza e la disponibilità a farsi aiutare. Ci si può sentire disorientati, feriti, fragili, violati. Ci si confronta con il senso della perdita, che è come un lutto, la perdita di una parte di sé a cui si era molto legati. Bisogna ricominciare a prendere confidenza col proprio nuovo corpo, acquisendo una nuova sensibilità e delle nuove competenze. Ma senza fretta.
Una metafora che uso spesso è quella del pianista che impara in modo sbagliato un brano musicale, e dopo deve re-imparare a suonarlo in un modo diverso. È una fatica bestiale! Molto più difficile che cominciare da zero. Ecco, mentre il bimbo di 2-3 anni impara da zero a riconoscere i segni del suo corpo, l’adulto che perde una procedura appresa e deve acquisirne di nuove, fa una triplice fatica: la fatica di abbandonare i vecchi schemi, la fatica di apprendere procedure nuove (questo può essere particolarmente difficile per i più anziani), la fatica di elaborare importanti vissuti emotivi, che ulteriormente complicano il processo di riadattamento dello schema corporeo.
Talvolta i pazienti si arrabbiano con se stessi per la loro incapacità di diventare autonomi nella gestione della stomia, o per il fatto di sentirsi emotivamente fragili. In queste circostanze, a volte può essere utile richiamare alla memoria la parte del Sé che ha svolto funzioni di accudimento, cioè la parte che è stata madre, padre, o che ha curato con amorevolezza un nipotino. Quando le persone vengono portate a pensare al Sé ferito come ad un bambino, da sostenere mentre affronta circostanze di vita difficili, diventa più facile abbassare i toni di rabbia e contattare un maggiore senso di compassione verso di sé. Questo non risolve tutti i problemi, ma aiuta ad avere più pazienza e senso di speranza, a vedere l’impasse attuale come una fase di un percorso di cambiamento, che può essere anche un cambiamento evolutivo.
Questioni emotive
Non tutti hanno presente che, nell’adattamento psicologico ad una malattia grave, come una diagnosi oncologica, o a un cambiamento dell’immagine corporea, sbalzi emotivi anche forti sono fisiologici. A volte i familiari si spaventano nel vedere le reazioni emotive della persona ammalata, interpellano i medici per sapere se sia “normale” che il proprio congiunto pianga tutto il tempo, o abbia reazioni rabbiose nei loro confronti. Nella mia esperienza mi è capitato di trovare medici ben preparati ad accompagnare i familiari in questo percorso, dando loro quel conforto di cui hanno bisogno, insieme a medici che si fanno spaventare a loro volta e che quindi richiedono l’intervento dello psicologo come via di fuga da un groviglio di ansie generalizzate. Un intervento banale, ma fondamentale, che fa lo psicologo, è quello di normalizzare i vissuti. Dire: “ok, adesso sembra Hulk, ma ci mancherebbe che non lo fosse!”.
Sebbene il rischio di una complicanza psicologica sia da valutare con attenzione, sentirsi depressi, arrabbiati o spaventati è del tutto normale nei primi mesi dopo l’intervento o la diagnosi. Si tratta di un processo che prevede una sequenza di fasi diverse, la cui evoluzione però fluttua in modo non lineare, cioè, non si pensi che prima viene lo step 1, poi lo step 2, e così via; è sempre un su e giù di montagne russe, fino alla stabilizzazione in un nuovo equilibrio. A volte sembra di oscillare tra uno stato d’animo e l’altro; momentanei periodi di serenità, si alternano a ricadute emotive, nelle quali ci si confronta con qualche aspetto diverso della situazione, a cui l’intero organismo deve trovare un senso. Potremmo sintetizzare le principali “fasi” o passaggi così:

Nessuno di noi vorrebbe fare esperienza di vissuti dolorosi. È normale volerli evitare. Tuttavia, per potersi adattare ad un cambiamento di vita importante, bisogna riuscire a tollerare l’ampia gamma di emozioni, consapevoli che ognuna svolge un ruolo prezioso nel processo di adattamento. La tristezza, ad esempio, può predisporre la persona ad affrontare il senso di perdita, prendere coscienza del cambiamento per poter poi rivolgere le proprie energie ad altri obiettivi di vita.
Ci si trova davanti alla necessità di bilanciare due bisogni emotivi diversi:
- Da una parte, accogliere eventuali sentimenti negativi, fisiologici, per prendersene cura;
- Dall’altra mantenere spazi liberi dalla sofferenza, momenti di piacevolezza e benessere dove potersi ricaricare.
L’IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA
Naturalmente questo percorso riguarda non solo il paziente ammalato, ma tutto il suo sistema familiare. Froma Walsh parla di resilienza familiare, per intendere la straordinaria capacità delle famiglie di riadattarsi ai cambiamenti di vita difficili, mettendo in campo competenze talvolta impensate. I principali insegnamenti della resilienza familiare sono:
Stare uniti nelle difficoltà
Nessuno è un eroe solitario
È importante che ogni membro della famiglia cerchi di dare calore emotivo e di collaborare alla gestione dei problemi, nel rispetto dei propri ruoli e competenze. Ad un livello pratico, occorre ridistribuire i compiti domestici fra i vari membri della famiglia in modo da mantenere l’organizzazione complessiva, anche nei periodi di cambiamento e stress.
Al contempo, quando il paziente recupera energie e autonomia, è altrettanto importante che possa tornare a svolgere le attività di un tempo (ove compatibile col quadro clinico attuale), in modo tale che la sua condizione di dipendenza, fisiologica e necessaria in un certo periodo, non vada poi incontro a cronicizzazione.
Una rete di supporto
Nessuna famiglia è un’isola.
Poter contare su di una rete di supporto fatta di amici, conoscenti e altri familiari in grado di dare una mano sia dal punto di vista pratico che emotivo, è fondamentale per consentire ad ognuno di ricaricarsi e mantenere l’ottimismo. Se nella storia di vita personale ci si trova a vivere da soli e non si è abituati a contare sull’appoggio di amici o fratelli/sorelle, può essere utile cercare altre fonti di supporto, ad esempio parlandone coi propri curanti.
Comunicare le emozioni
A volte le persone parlano poco dei loro sentimenti, si isolano o si chiudono in se stesse, per timore di ferire coloro a cui vogliono bene. Il paziente può sentirsi responsabile non solo di gestire il proprio turbamento, ma anche quello dei suoi congiunti. Di conseguenza, può limitarsi nel confidarsi o nell’esprimere liberamente i suoi vissuti per timore di risultare pesante, di infastidire o di creare preoccupazione.
I familiari, dal canto loro, a volte cercano di sollecitare il paziente ad esprimere solo emozioni positive, pensando che questo sia il modo migliore per aiutarlo a “reagire”. A volte ciò che aiuta ad andare avanti è la possibilità di sentire vicinanza anche nei momenti più neri. Sapere che, anche quando si è molto arrabbiati o impauriti, la propria famiglia ci accetta ugualmente.
In sostanza, bisogna trovare volta per volta un bilanciamento fra lo stare insieme nella difficoltà e lo spronare ad “andare avanti”. Non è facile capire quando sia il momento giusto per l’una o l’altra cosa, ma ascoltando le reazioni degli altri ai propri commenti e parlando in modo esplicito di come ci si sente e di cosa si avrebbe bisogno (invece di dare per scontato che gli altri lo “intuiscano”), è possibile migliorare la sintonia su questi aspetti della comunicazione.
COMUNICARE COI BAMBINI:
Alcuni genitori pensano che per “proteggere” i loro figli sia meglio nascondere i problemi degli adulti. Peccato che i bambini anche molto piccoli capiscono sempre quando in famiglia ci sono delle preoccupazioni, perché le sentono attraverso il cosiddetto “linguaggio non verbale”.
Se gli adulti non li aiutano a dare un senso e a gestire l’ansia evocata in loro, i bambini rischiano di creare fantasie drammatiche o di darsi la colpa per le tensioni dei genitori, rimanendo da soli coi propri dubbi.
Ovviamente bisogna trovare un modo per comunicare con loro che sia adeguato all’età e alla loro possibilità di comprensione. Se sono bimbi in età prescolare, ad esempio, si può provare a disegnare una storia insieme a loro, per spiegare ciò che sta accadendo e che, anche se il corpo di mamma o di papà è cambiato, continueranno a prendersi cura di loro allo stesso modo.
A volte gli adulti si fanno molti più problemi di quanti se ne facciano i più piccoli. Parlo di quelle situazioni nelle quali i genitori temono che i loro bambini possano rimanere eccessivamente turbati dal vedere, ad esempio, la cicatrice sulla pancia, o il sacchetto della stomia. Certo, non bisogna esporli in modo brutale, ma con naturalezza aiutarli a vedere quei cambiamenti come qualcosa “che si può affrontare”, che può diventare una nuova normalità. Molti di loro saranno incuriositi, faranno domande, più per capire meglio e condividere coi genitori il cambiamento, che per dei veri e propri timori. E nella spontaneità dell’accettazione dei propri figli, per i quali “la mamma è sempre la mamma” e “il papà è sempre il papà”, anche i genitori possono scoprire che adattarsi al cambiamento è possibile.
Riferimenti bibliografici:
Bullen T.L., Sharpe L., Lawsin C., Chauhan Patel D., Clarke S., Bokey L. (2012). Body image as a predictor of psychopathology in surgical patients with colorectal disease. Journal of Psychosomatic Research 73 (6), 459–463 http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.08.010
De Salvo G., Tissot A. (2001). Il corpo estraneo. Colloqui con portatori di stomia negli ultimi 35 anni. Hameau de la piscine (Valle d’Aosta): Wesak editions
Fingren, J., Lindholm, E., & Carlsson, E. (2013). Perceptions of phantom rectum syndrome and health-related quality of life in patients following abdominoperineal resection for rectal cancer. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 40(3), 280-286 doi: 10.1097/WON.0b013e31827e8b20
Fingeret, M. C., Teo, I., & Epner, D. E. (2014). Managing body image difficulties of adult cancer patients: lessons from available research. Cancer, 120(5), 633-641
Galimberti, U. (1987). Il corpo. Milano: Feltrinelli Editore
Krouse, R. S., Grant, M., Rawl, S. M., Mohler, M. J., Baldwin, C. M., Coons, S. J., & Ko, C. Y. (2009). Coping and acceptance: The greatest challenge for veterans with intestinal stomas. Journal of psychosomatic research, 66(3), 227-233.
Pozzi, S., Magrin, M. E., & Scrignaro, M. (2015). Stomia e crescita post-traumatica: uno studio esplorativo mixed-method. Psicologia della Salute, 15, 24-44
Ricci Bitti, P.E., & Gremigni, P. (2013). Psicologia della salute: modelli teorici e contesti applicativi. Roma, Carocci.
Saita, E. (2009). Psico-oncologia: una prospettiva relazionale. Milano: Unicopli
Salter M. (1992). What are the differences in body image between patients with a conventional stoma compared with those who have had a conventional stoma followed by a continent pouch? Journal of clinical nursing, 12, 117-123
Saviano, M., Tedeschi, M., Carriero, A., Ricchi, E., Spallanzani, A., & Saviano, L. (1998). Phantom rectum after Miles’ operation. Minerva chirurgica, 53(12), 1027-1033.
Walsh, F. (2008). La resilienza familiare. Milano, Raffaello Cortina.